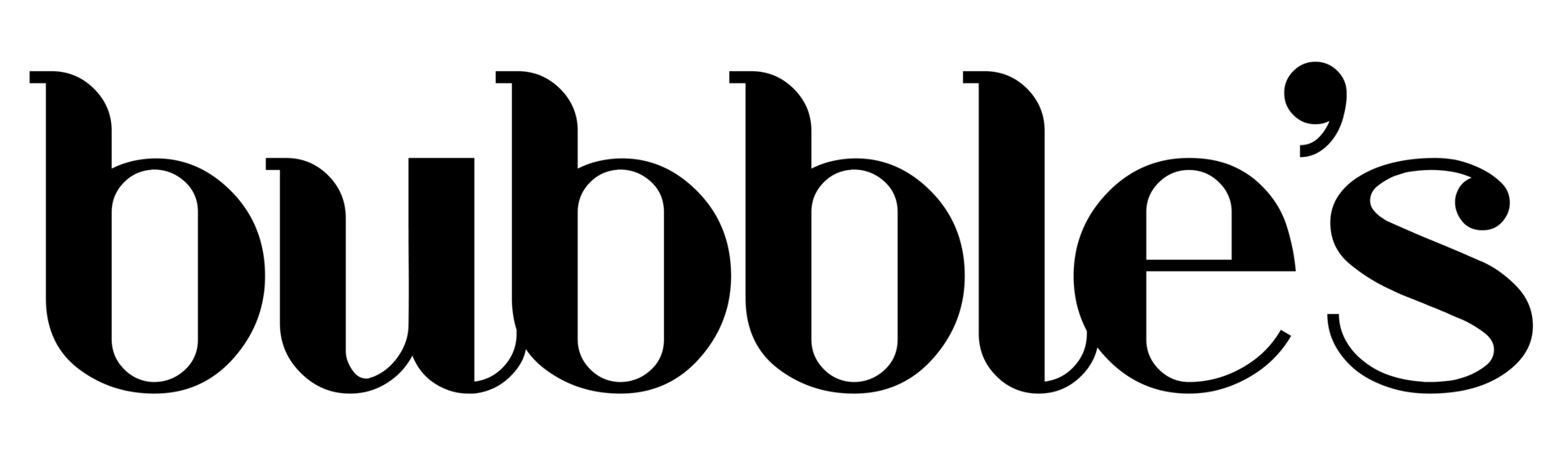Guardare al passato per relazionarsi meglio con il futuro
di Franco Adami
Quando incontra degli amici succede sempre più spesso che i suoi discorsi scivolino sui tempi andati.
Gli piace guardarsi indietro, dando poco peso che questo si identifichi con il fatto che io stia invecchiando, perché pensare alle origini del suo cammino nel vino scalda i suoi pensieri come solo i ricordi belli riescono a fare. Del resto senza memoria non saremmo niente ed è per questo che se la tiene stretta affinché tutti i momenti che hanno scandito il suo quotidiano e tutte le persone che lo hanno riempito non scompaiano mai dalla sua mente. Annota le vendemmie, i volti, i sapori dei vini che produce, i profumi delle persone che conosce, le parole, i gesti e le sensazioni che vive, cercando di interpretare come le sue scelte (gli) abbiano indirizzato il suo cammino domandandosi, guardandosi indietro, come era e cosa è diventato.
Si vede diverso lontano da quel mondo vitivinicolo in cui è cresciuto e facendone ancora parte riflette su come lo abbia realmente modificato. Ha vissuto la tradizione contribuendo a non renderla mai statica, evolvendo idee e opinione, dando valori a cose che non ne avevano. Anche i risultati ottenuti via via, hanno assunto un altro peso, accorgendosi d’essere il sunto di tante strie, quelli di chi lo ha preceduto. Crede di essere l’insieme di tante rivoluzioni attivate dai vignaioli della sua famiglia i quali, nell’ultimo secolo, hanno cercato di modificare il proprio modo d’interpretare il vino.
“Mi raccontava mio padre che Abele Adami, mio nonno, a partire dagli anni Venti e fino agli anni Cinquanta del secolo passato, vinificava il suo Prosecco in botti di castagno da lui stesso prodotte, macerando le bucce fino a fine fermentazione, Quando mio padre Adriano decise, non condividendo questa arcaica metodologia di vinificazione, di cambiare strada acquistando vasche di cemento e limitandosi a una fermentazione con le bucce che non andasse oltre l’alzata del cappello, mio nonno Abele lo redarguì fortemente dicendogli:
“Jano, (così lo chiamava) tu mi rovini il vino”.
Quando anche Armando ed io, come enologi, decidemmo all’inizio degli anni Ottanta, del secolo scorso, di cambiare tutto acquistando le presse pneumatiche e dei serbatoi di acciaio inox oltre a un impianto di refrigerazione per vinificare in bianco a temperature controllate, dovemmo ascoltare da Adriano la solita frase:
“figli miei, ma così mi rovinate il vino”.
Sono passati anni in cui ne ho fatte altre di rivoluzioni alcune delle quali hanno stravolto in modo radicale il mondo del Prosecco. La più importante e stata quella culturale, tecnica, programmatica, con la quale ho indirizzato la modifica e trasformazione del vino che produco non in un prodotto enologico migliore, ma in un concetto di territorio, pensando che facendo così avrei contribuito, insieme a tanti altri, a dare valore a un progetto d’area rivolto verso il mondo esterno e verso le generazioni future.
Sì, ho contribuito alla rivoluzione del Prosecco, per difendere e dare valore a questo fazzoletto di terra che va da Valdobbiadene a Conegliano. Un salto di paradigma importante, dirompente, di rottura che comunque non ha modificato il mio attaccamento al passato. Oggi mi confronto con Fabrizio, mio figlio Fabrizio, anche lui enologo.
La quarta generazione della famiglia. Non spetta a me dirlo, ma è un bravo ragazzo che sta facendo la sua rivoluzione proponendo di tornare alle vasche di cemento controllando le temperature della macerazione per svinare prima dell’inizio della fermentazione. Come le vasche in cemento? Non capivo spingendomi fino al punto di ripetergli anche a lui la frase comune che si tramanda a ogni passaggio generazionale:
“caro figlio, così mi rovini il vino”.
Preferii tacere comprendendo che le cose cambiano e con il passare degli anni c’è bisogno di un continuo adattamento della produzione rispetto alle nuove scoperte scientifiche, ai mutamenti del gusto dei consumatori, all’evoluzione culturali dei mercati che sostengono nuovi valori come la sostenibilità e la salubrità dell’ambiente. Sempre più c’è la necessità di misurarsi con i cambiamenti climatici in atto, senza dover modificare la riconoscibilità dei vini prodotti e del territorio che ha contribuito a produrlo.
Mi trovo a disquisire con lui su ogni punto di possibile intervento che possa modificare, garantire, preservare, tutelare e far evolvere il sistema di area, sapendo che il collegamento cardine che unisce tutte queste parole siamo noi.
Abele allevava la vite avendo bisogno di una viticoltura di sussistenza. Ogni terreno veniva valorizzato, la vite trovava posto in collina, cereali in pianura così come il foraggio per gli allevamenti che fornivano l’unico concime utilizzato in vigna posta su terreni ripidi, magri e poco profondi. Le piante avevano una scarsa produttività e avevano bisogno di essere seguite con maniacale attenzione. Un lavoro duro scrupoloso e attento. È stata quella viticultura praticata in modo eroico a portare il riconoscimento di patrimonio dell’umanità a questo areale da parte dell’UNESCO. Adriano negli anni 70 abbandonato l’innesto in campo praticato dal padre, si indirizzò verso la coltivazione di cloni più produttivi, caratterizzati d chicchi più grandi e grappolo compatto. Anche la concimazione divenne esclusivamente minerale, mentre la resa per ettaro delle uve aumentò sostanziosamente.
Con mio fratello Armando ritornammo a produrre barbatelle con i vecchi cloni di Abele, prelevati in campo, infittimmo il vigneto cercando un equilibrio diverso pur mantenendo la produzione su buoni livelli. La concimazione divenne misto-organica e anche i portinnesti scelti erano quelli più adatti al terreno ed alla posizione. La quarta generazione, quella di Fabrizio, guarda al passato, preferendo portinnesti resistenti alla siccità, una concimazione organica e attivando un inerbimento dei vigneti per fissare azoto sul terreno, con l’intento di arrivare quanto prima a eliminare del tutto le concimazioni, avendo ben chiaro, come un Karma, che l’approccio alla viticoltura è prima sostenibile e poi redditizio.
Le analisi del terreno sfiorano quelle di un check-up ospedaliero e l’attenzione alla vitalità del terreno è totale. Devo ammettere che la qualità dell’uva è migliorata molto pur mantenendo buona la quantità, fattore quest’ultimo oggi secondario rispetto al primo. Tutto cambia, ma è chiaro che per effettuare un cambiamento è necessario avvalersi della tradizione tenendo viva la memoria, ed è questo che mi esercito a fare, ogni giorno.”