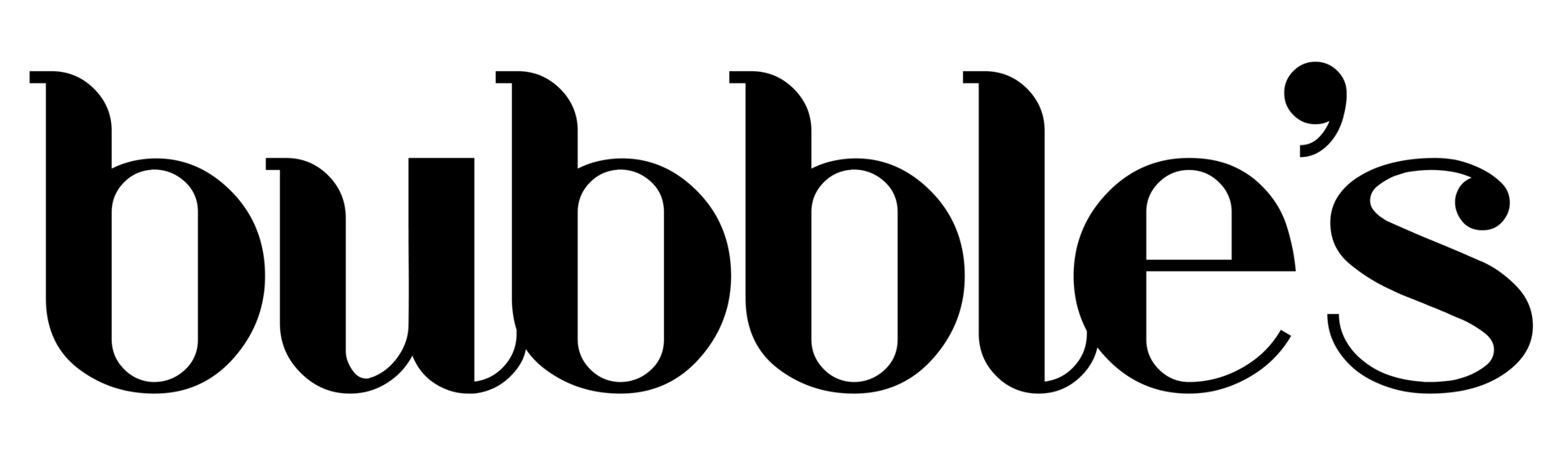Il mio ritorno a casa
Di Matteo
Entrare dentro una grande storia come quella che accompagna l’Ambasciata di Quistello non è stato semplice. Quando mi hanno proposto di tornare per prenderne le redini, questo ristorante, dove avevo già lavorato per qualche anno, il ristorante era sull’orlo del baratro. Da un lato affrontare una nuova sfida mi infondeva entusiasmo, mentre dall’altro il timore di non riuscirci mi faceva tremare i polsi. Una moltitudine di sensazione si accavallavano, dopo aver passato anni nelle cucine di grandi ristoranti al fianco di chef stellati, dentro mi sentivo crescere l’orgoglio di aver raggiunto un traguardo importante e poter contare finalmente su qualcosa di mio, dall’altra ero intimorito al cospetto della responsabilità di dover aggiungere ancora pagine epiche alla leggenda che accompagna questo locale. Ne sarei stato capace? Tutte le mie sicurezze, la mia sfrontatezza, il narcisismo che mi aveva sorretto era tremolante. Sarei dovuto entrare in punta di piedi dentro questa cattedrale del gusto con l’umiltà del principiante. Conoscevo tutto di questo locale; ogni suo angolo e ogni libro che compone le colonne che sembrano sorreggerne il soffitto; avevo spostato e rimesso a posto centinaia di volte ogni tavolo e sbattuto contro ogni spigolo della cucina dove avevo imparato l’Arte di fare “le Paste”. Nonostante questo, sentivo il peso della storia di cui sono intrise le pareti dell’Ambasciata, quella che avevo già attraversato in passato annusandone la potenza. Sapevo che riportare in auge un monumento della ristorazione italiana, ai miei occhi, risultava difficilissimo, complesso se non fallimentare. Ma cosa mi mancava per riuscirci? Nulla.
Perché pensavo, fra me e me, che l’aver dedicato la mia vita alla cucina voleva pur avere un significato, così come doveva averne l’aver acquisito in altri paesi del mondo esperienze di ogni genere in questo settore, toccando apici di onnipotenza e momenti di depressione, asciugando lacrime di sconforto nella più assoluta solitudine, quella che ahimè avvolge, di solito, coloro che fanno questo lavoro con estrema passione. Cosa mi mancava per riuscirci? Una sola cosa: la certezza che la cocciuta determinazione che mi aveva sempre contraddistinto non venisse meno. MI ripetevo che in tante altre occasioni avevo testato la mia convinzione di voler fare il cuoco a tutti i costi, a partire dal momento in cui uscii di casa, a 20 anni, dopo aver litigato in famiglia, comunicando ai miei genitori che non avrei mai perseguito la professione di geometra, ma quella di cuoco. Una cocciutaggine che mi aveva portato a lavorare gratis pur di entrare in una cucina, facendo di notte il trattorista per pagare l’affitto di uno squallido buco d’appartamento dove mi ero traferire dopo essere uscito di casa. Non ci si inventa né cuochi e soprattutto Chef, così come non si diventa bravi senza sacrifici che ho compreso sulla mia pelle, vanno ben oltre ciò che è visibile ai più. La passione iniziale lascia spazio alla passione che si scopre piano pian, arrivando a comprendere di averlo dentro questo mestiere, sentendolo mio, innamorandomene perdutamente. Compresi che avrei dovuto dare valore a ogni giornata, con la curiosità di un bimbo, perché, in questo lavoro, non ci possono essere giornate storte, ma solo quelle belle. Questi convincimenti mi hanno accompagnato ovunque andassi, passando da commis di cucina a Chef, solendo le scale del successo e scendendo quelle brucianti delle sconfitte che sono sempre dure da digerire e delle quali devo dare la colpa solo a me stesso. Ma servono, sono importanti e danno più valore a ciò che faccio, soprattutto quando è l’amore che nutro per questo lavoro, a darmi l’energia per riemergere. Sono pensieri che ripercorrono un passato, arrivando fino a mia madre, alla sua devota e amorevole attenzione verso suo figlio chiedendomi, quando tornavo a casa: hai fame? Cosa ti preparo? Una frase d’amore che ripeto dentro me stesso ogni volta che qualcuno supera la soglia dell’Ambasciata e si siede con il piacere di gioire di ciò che faccio.